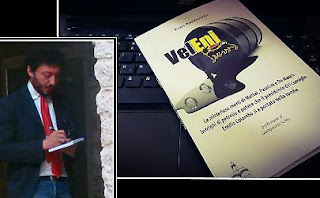A tu per tu con Michele Salfi Russo, cugino di Francis Ford Coppola e regista del premiato docufilm “ The Family Whistle”, racconta le origini della famiglia Coppola.
Conosciamo meglio Michele Salfi Russo, autore e regista del docufilm “The Family Whistle”. Quando si è acceso il “sacro fuoco dell’arte”? Raccontaci le tue origini e i tuoi percorsi…
L’arte fa parte di me da sempre. É una condizione naturale non solo mia ma di tutta la mia famiglia: la creatività, la curiosità, la voglia di leggere fra le righe quello che mi si presenta davanti, fanno da sempre parte di me. Il mio percorso artistico nasce e si sviluppa in un habitat naturale, che è quello di casa mia. Mio padre è stato un grande storyteller, sia come maestro elementare, sia nella sua vita privata. Ho preso da lui questa capacità di raccontare storie. Mia madre, invece, è colei che ci ha sempre spronato a inseguire i nostri sogni. La fortuna di avere avuto genitori così viene completata con la figura dei miei fratelli: Gaetano, un talento straordinario, un artista versatile; Riccardo, un bravissimo musicista; mia sorella Lella, brava scultrice e arredatrice, sposata con un musicista, a Londra. Come ti dicevo, una famiglia di artisti…
Come dicevi, la tua è una famiglia di artisti. Questo lo spieghi bene nel tuo documentario “The Family Whistle”, in cui racconti la storia della famiglia Coppola e di come tu sia riuscito a ricostruire l’albero genealogico a partire dal 1775, ricongiungenti con loro. Sei cugino di Francis Ford Coppola. Come ci si sente ad essere cugino di uno dei più grandi registi della storia del cinema? Ci racconti esperienze, sensazioni ed emozioni provate, stando al suo fianco?
La mia nonna paterna era cugina di primo grado con Agostino Coppola, il nonno di Francis. Scopro proprio partendo dal cinema, come luogo, di essere suo parente e nel docufilm racconto tutto questo. Era difficile ricucire la tela della famiglia Coppola, ma in 25 anni di ricerche, sono riuscito a completare l’albero genealogico di tutta la famiglia e in otto anni a realizzare il docufilm. Un giorno, rimettendo a posto vecchie lettere, trovai quella di Carmine Coppola e chiesi a mio padre spiegazioni su questa nostra parentela con loro. Da lì cominciai il mio grande percorso di ricerca, nonostante le difficoltà a ricostruire tutto quel tempo perduto. Quando iniziai le ricerche, negli anni 80, non c’era internet, non c’era modo immediato per contattare le persone. Fu per caso, ascoltando una conversazione tra il mio regista e un suo amico, che riuscii ad avere finalmente modo di contattare Francis. Scrissi a Francis il primo Aprile del 1988. Lui mi rispose a Giugno, scrivendomi che mi avrebbe raggiunto a Cinecittà, l’autunno seguente. Finalmente ci incontrammo e fu un incontro molto emozionante. Conobbi suo padre, sua madre, suo fratello Agostino, il papà di Nicholas Cage. Gli dissi: “Francis è ora che tu torni a Bernalda”. Nella Primavera dell’ 89, venne a Bernalda, gli diedero la cittadinanza honoris causa e, in tutto questo percorso di ricongiungimento con luoghi e persone, non feci altri che alimentare la sua curiosità, che rimane ancora oggi viva, dopo venticinque anni dalla nostra reunion. Rcominciò a frequentare Bernalda e comprò questo palazzo ottocentesco, Palazzo Margherita, facendone un resort, dove anni dopo si sarebbe sposata sua figlia, la regista Sofia Coppola. Grazie alla realizzazione del documentario siamo riusciti a conservare la memoria storica, che tutti dovremmo tenere ben stretta, indipendentemente dal pregio, dalla celebrità della famiglia a cui apparteniamo. Ho semplicemente raccontato la storia di una famiglia di origini italiane con l’arte nel sangue, che è riuscita ad esportarla in tutto il mondo.
L’idea di realizzare un docufilm del genere, da dove nasce? C’è stato un evento scatenante?
Per scrivere un film occorre ci sia una “spina dorsale” e l’idea nasce davanti a un bicchiere di vino, mentre raccontavo a Francis le storie di nonno Agostino. Lui mi disse: “ Sei tu che dovresti fare il film perché sei tu che conosci bene la storia, hai talento e mi piace come la racconti” . Così cominciai a girare. In occasione del matrimonio di Sofia, proiettai per la prima volta il premontato del documentario. Vidi Francis commosso e mi disse: “ Michele, possiamo mostrarlo al mondo” e così abbiamo fatto. La sua approvazione mi ha ripagato di tutto. Tutto questo è un sogno che è diventato realtà, come mamma mi ha insegnato. Agostino, diceva: “Fate la vostra vita ma non perdete mai la musica”; mia mamma diceva: “Fate la vostra vita ma non smettete mai di sognare”.
Vedendo il documentario si capisce il legame profondo che hai con Bernalda. Cosa rappresenta per te?
A Bernalda c’è una grande possibilità di respirare il tempo. C’è la possibilità di non avere fretta, di avere il tempo di osservare le cose, di contemplarle e di viverle. Credo Bernalda sia stata una grande opportunità per sviluppare la nostra creatività in famiglia.
Hai dimostrato un esordio notevole con questo docufilm, ricevendo, nel 2016, il primo premio come miglior fotografia al Boston International Festival. Hai lavorato a fianco di Francis ne Il Padrino - parte III e con Giuseppe Tornatore in Bàària. Che cosa ti hanno insegnato due registi di quel calibro?
Sono due registi enormi e da loro si impara davvero molto. Lavorare al loro fianco è stata un’ esperienza memorabile. Sono registi dotati di grande professionalità e umanità, che amano gli attori con cui lavorano, che costruiscono insieme all’attore il film e i personaggi. Non sempre si ha la fortuna di lavorare con registi del genere…
Quali sono i tuoi registi di riferimento e a quale tipo di cinema senti appartenere di più?
Ci sono grandi registi ovunque, ognuno nel proprio genere. Se dovessi scegliere direi Frank Capra, che ha saputo raccontare magistralmente il sogno americano e il sogno in genere; poi Kurosawa, Kubrick e tanti altri. Sono molto legato al neorealismo, quella verità assoluta, quelle immagini forti erano sensibilmente appetibili e mi emozionano sempre. Mi piace leggere tanto e di tutto, ascoltare tanto e tutto. Attingo da tutto. Ogni linguaggio è diverso e interessante.
Intorno a te hanno gravitato artisti di un certo livello per creare il docufilm, come ad esempio tuo fratello Gaetano Russo, uno tra gli scenografi italiani più bravi. Chi è per te Gaetano, oltre ad essere tuo fratello, e che ruolo ha avuto nella creazione del film?
Gaetano è la luce, un vero artista. Riesce a dare pennellate di colore anche sulla mia tavolozza, se sto scrivendo o girando un film. Ha sempre intuizioni geniali e riesce a dare un senso a tutto, ad animarlo. Ci siamo sempre aiutati l’un l’altro. Gaetano è una grande opportunità, oltre che un grande fratello. Al docufilm, invero, ha contribuito tutta la famiglia: da Gaetano nell’estetica, nella grafica, scenografia ed ambientazione, a Riccardo per le musiche sino a tutti i consigli ricevuti dagli altri membri. L’idea grafica è di Gaetano: l’albero genealogico che da cinque generazioni diventa pentagramma esprime esattamente ciò che lega la nostra famiglia : la musica
Hai altri progetti? E se sì, ci puoi svelare qualcosa in anteprima?
Ho finito di scrivere una sceneggiatura che vorrei girare in Basilicata, fra i sassi di Matera, tratta da una storia realmente accaduta un secolo fa e che si muove attorno ad un personaggio cardine di questa storia che, guarda caso, è un sognatore. É un personaggio che pensava, attraverso l’arte, di risollevare la condizione miserevole in cui versava la Lucania in quel tempo. I lucani sono sognatori per antonomasia.
Un ultima domanda, la più significativa: cosa rappresenta per te il fischio? Ti capita di usarlo realmente?
Sì, conservo il mio fischio, un po’ per gioco, un po’ per istinto. Lo uso con mio figlio come faceva papà con noi per richiamarci se era pronto il pranzo, se eravamo al mare o per strada giocare. Il fischio è musica, è un suono fatto da poche note, che distingue una famiglia dall’altra; che distingue una cultura, una forma mentis, se così si può dire, da una famiglia all’altra. É senso di appartenenza del nucleo familiare e della comunità. Dentro al fischio ci sono tutte le sfumature di paura, consigli, raccomandazioni, spensieratezza, gioia. É un mezzo vero e proprio di comunicazione che sostituisce le parole. In quelle tre note senti tutto. É musica e, d’altronde, nella nostra famiglia, non poteva essere mezzo migliore.